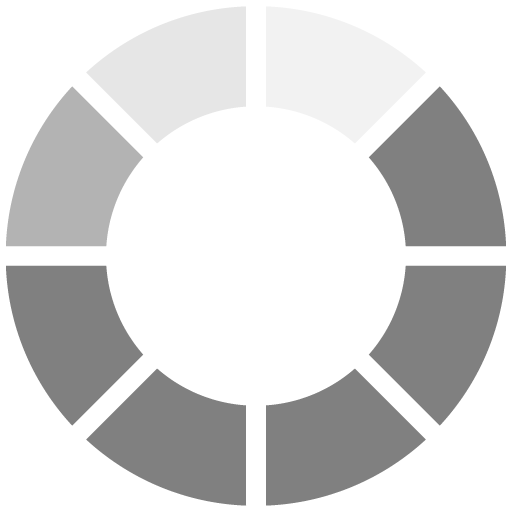Riflessioni sui vissuti dei confini umani
Le motivazioni che portano una persona al suicidio sono diversissime e, in gran parte, impenetrabili. Solo talvolta possiamo intuirne le ragioni.
Cercherò quindi – come operatrice del servizio ADVAR Rimanere Insieme che da anni se ne occupa – di mettere in luce alcuni aspetti e spunti di riflessione.
Alcune motivazioni del gesto
Il panico è una delle motivazioni che possono spingere al gesto suicidario. È quel che accadde al filosofo ebreo tedesco Walter Benjamin che si uccise per non essere catturato dai nazisti, dopo che gli era stato negato il visto di transito per gli USA. Vengono colte dal panico anche persone che, alla notizia di avere un tumore terminale o una malattia degenerativa, non sopportano il pensiero di vivere con questo incubo incombente e scelgono di togliersi la vita. Non dimentichiamo poi gli anziani che rimasti soli, in alcune circostanze preferiscono la morte ad una vecchiaia vissuta nel completo isolamento.
A volte il suicidio ha una motivazione politica, per far sentire all’intero mondo la condizione di sofferenza in cui uno Stato o un gruppo è costretto a vivere.
Mi riferisco, per esempio, alla morte di Jan Palach il 21 agosto 1969 che immolò la propria vita dandosi fuoco, per esprimere il suo dissenso contro l’invasione russa a Praga, o al vescovo pakistano John Joseph che, nel 1998, a Faisalabad, si sparò alla tempia davanti al tribunale locale per protestare contro le leggi sulla blasfemia. Forme di proteste estreme di tipo politico che conducono al gesto suicidario sono anche quelle dei monaci buddisti tibetani che, nel secolo scorso, si sono dati fuoco per opporsi al regime cinese.
A volte è la vergogna per gli atti commessi o per gli ingenti debiti accumulati a spingere le persone a uccidersi.
Esistono poi forme di morte che, pur non venendo definite suicidio, possono essere considerate ugualmente tali. Intendo quelle morti che avvengono per la scelta di praticare sport estremi, laddove non ci si toglie de facto la vita, ma la si sfida mettendosi volontariamente in situazioni di pericolo. Anche l’assunzione di sostanze che creano dipendenza, l’uso smodato di medicinali, uno stile alimentare inappropriato possono condurre alla fine di una esistenza.
Culture di appartenenza e prospettive diverse sul tema del suicidio
Un’altra considerazione che voglio portare riguarda il modo in cui il suicidio è considerato dalla nostra cultura di appartenenza.
In generale per lungo tempo ha avuto influenza su tale tema il pensiero cattolico.
La Chiesa cattolica considerava il suicidio un peccato grave e mortale, una trasgressione al quinto comandamento: non uccidere.
Nel catechismo del 1992, tuttavia, all’interno del capitolo dedicato al comandamento “Non uccidere”, nei numeri 2280-2283, la Chiesa condanna sì il suicidio, ma non necessariamente chi commette l’atto.
Infatti, così è scritto nel n. 2283:
Non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l’occasione di un salutare pentimento. La Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita.
Si tratta dunque di una nuova visione misericordiosa rispetto alla dura condanna degli anni e dei secoli precedenti. Ciononostante, anche tra le persone laiche, lo stigma continua a essere ancora piuttosto radicato. Non è facile rivelare, senza reticenze, che un proprio familiare si è tolto la vita.
Se diamo uno sguardo ad altri tempi o ad altre culture, notiamo che il suicidio può essere visto più come possibilità che come oggetto di condanna: per esempio, in Giappone, il Harakiri era una forma di suicidio propria della casta dei samurai che in questo modo o si sottraevano alla morte capitale, o manifestavano solennemente la propria protesta contro un’ingiustizia subita, o esprimevano il proprio dolore per la morte del loro signore (ma è stato praticato anche in tempi più recenti, da militari, uomini politici, alti funzionari).
(https://www.treccani.it/vocabolario/harakiri).
Ricordiamo anche lo Stoicismo, in particolare Seneca che nella lettera 70 a Lucilio considera il suicidio come affermazione suprema di libertà: egli la definisce un’opzione sempre praticabile per l’uomo, che in ogni momento può così facilmente sottrarsi al capriccio della sorte e alle avversità della fortuna.
Nel film del regista coreano Kim-Kik-duc, Primavera, estate, autunno, inverno … e ancora primavera, storia di un maestro e del suo discepolo, il maestro, giunto alla vecchiaia e ritenendo di avere trasmesso il senso della vita al suo discepolo, si toglie con molta serenità la vita.
La sofferenza di chi sceglie di togliersi la vita
L’esperienza di Rimanere Insieme – attraverso colloqui e gruppi con i familiari delle persone che si sono tolte la vita – ci mostra da anni che i suicidi sono l’esito di una grande sofferenza. Enzo Bianchi, monaco cattolico e saggista, ne parla così:
Chi sceglie il suicidio se ne va con il suo segreto, al di là delle dichiarazioni che fa e può fare sulla drammaticità della sua condizione, sul dolore che patisce e al quale vuol sottrarsi. Ci sono persone dotate di una sensibilità e di una vulnerabilità tali che non permettono loro di sentire questa vita come sopportabile e di nutrire speranza: esse desiderano soltanto la pace, il riposo, la fine dei dolori fisici o della sofferenza psichica.
Enzo Bianchi, Cosa c’è di là, Il Mulino, Bologna 2022, p. 59.
Il vissuto di chi resta
Il dolore dei familiari – quelli che vengono definiti superstiti, i sopravvissuti è altrettanto atroce e, almeno per gran tempo, inconsolabile:
«Perché ha commesso questo gesto?»
«Perché non ha pensato a me?»
«Perché non mi sono accorto che stava così male?».
Sono queste le domande che ricorrono spesso. E quanti sensi di colpa! A volte sono un modo per spiegare l’inspiegabile, l’enigma che attanaglia. Infatti, noi esseri umani abbiamo bisogno sempre di trovare una causa per dare un senso ai fatti, dare ad essi una collocazione e un senso.
Dopo anni di lavoro con i superstiti, ritengo che al suicidio sia impossibile dare una spiegazione esauriente. Il gesto è, infatti, una decisione dell’altro, ci mette davanti agli occhi l’impossibilità di controllare e indirizzare la vita altrui. Questa è sempre responsabilità sua. Possiamo stare accanto, comprendere, aiutare, ma mai impedire all’altro di essere lui il primo responsabile della sua vita.
Imparare a stare con la domanda aperta, nella consapevolezza che non ci sarà mai una risposta esauriente al perché una persona abbia commesso quel gesto, è il lavoro che deve compiere il superstite. E nello stesso tempo è importante che chi rimane recuperi i ricordi e custodisca – nel legame d’amore che non si interrompe con la morte – l’intera vita del proprio caro, che non oscurata dall’ultimo estremo gesto.
Maria Augusta De Conti, équipe di ADVAR Rimanere Insieme