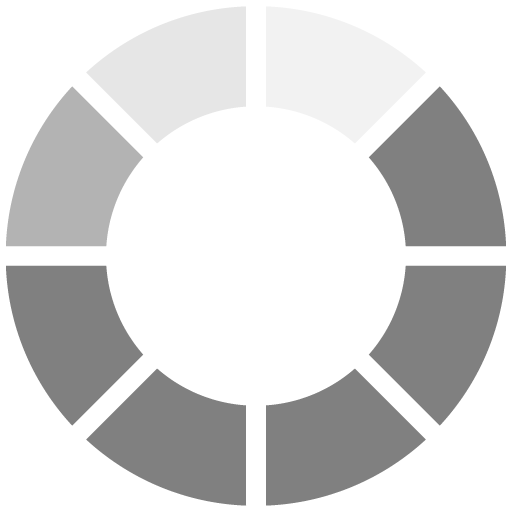La paura della vecchiaia
“Ma non abbiamo altro di meglio di cui parlare? Per carità, cambiamo discorso!”
Sono spesso queste le parole di risposta che udiamo quando, magari a tavola con gli amici, decidiamo di raccontare della morte di qualcuno che conoscevamo. Della morte è sconveniente parlare e, in certe situazioni, si rischia pure di apparire maleducati e fuori contesto. Questo si intende per tabù della morte. E la nostra cultura ne è immersa.
Come possiamo imparare a integrarlo nella nostra vita, per arricchirci reciprocamente di nuove consapevolezze? A parlarcene è la dott.ssa Maria Augusta De Conti dell’équipe di Rimanere Insieme ADVAR che da anni se ne occupa.
Il tabù della morte è un fenomeno proprio della nostra epoca e, per certi aspetti, ancora di più dei nostri giorni. Parallelamente a esso, cresce la necessità di migliorare l’aspetto fisico e dedicarsi alla cura del corpo, inteso come una macchina che, se continuamente messa a punto, illusoriamente non avrà mai problemi. Crediamo di avere un corpo e dimentichiamo, paradossalmente, che siamo un corpo su cui si riverberano forza e fragilità e il cui stato ci segnala una condizione che è sempre di tipo psico-fisico.
Il mito del benessere e la paura della vecchiaia
Il mito del benessere, dell’eterna giovinezza, del corpo perfetto da una parte, e dell’inesorabile perdita di valore degli anziani nella nostra società dall’altra, sono due fenomeni che, contraddittoriamente, oggi convivono. Le persone vivono molto più a lungo di un tempo e il numero degli anziani supera quello dei giovani. Eppure, non si è mai assistito, come in quest’epoca, a così tanta solitudine e poca considerazione per la terza età. Gli anziani – parola questa che è una specie di eufemismo per non pronunciare quella che terrorizza, cioè vecchi -, da parte loro, devono apparire sempre sorridenti, pronti a ballare, a sentirsi giovani e pimpanti, anche quando scendono dal montascale. Non c’è spazio per l’idea di una morte che si avvicina, passando pian piano attraverso la naturale perdita delle proprie abilità.
Un tempo, arrivare agli ottanta, novant’anni era quasi impensabile. Si moriva molto presto, spesso falcidiati in massa giovanissimi, durante le tante guerre che hanno flagellato l’umanità. Ci basti visitare un qualsiasi cimitero militare italiano per renderci conto di questo. Era, dunque, chiaro che la giovinezza era un periodo della vita, e non il paradigma della vita, un periodo destinato a passare presto per far posto alla maturità e, se si era fortunati, alla vecchiaia.
Il vecchio era trasmettitore di saggezza e di antichi saperi.
C’è una sequenza nel famoso film di Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, in cui il nonno insegna ai nipoti il segreto per far crescere le pianticelle di pomodori, per portarli per primi al mercato: le si colloca in un posto al sole vicino a un muro e, così, il calore del sole assorbito dalla parete favorisce la crescita precoce delle piantine.
Ora chi ci tramanda più queste semplici pratiche? Il vecchio è diventato una persona da accudire più che da ascoltare o da cui imparare. I giovani, dal canto loro, sono soprattutto attratti dalla tecnologia – i cosiddetti nativi digitali – su cui ormai si basa tutta la nostra società. Il risultato di tale separazione può ostacolare il dialogo intergenerazionale soprattutto su temi importanti come il dolore e la morte.
Il coraggio di parlarne
Una volta si poteva attingere a forme espressive, anche convenzionali e retoriche, che rendevano esprimibile la durezza della morte, perché non era scandaloso far convivere la morte con la vita. Inoltre, tutta la famiglia si presentava al capezzale del morente, e tutti vivevano insieme l’evento della morte, bambini compresi. La vecchiaia era venerata, anche se a volte era pesantissimo vivere sottomessi alla volontà del patriarca. Lo sentiamo dai racconti dei vecchi contadini ancora viventi. Quindi, non si tratta di avere nostalgia del buon tempo antico, ma di avere consapevolezza che la morte è il traguardo inesorabile a cui arriviamo tutti e che non possiamo non integrarla nella vita. Certo, per poter vivere in modo equilibrato, è necessario che la morte sia messa sullo sfondo, altrimenti saremmo travolti da un’angoscia paralizzante. Eppure, la consapevolezza che siamo destinati a morire e che una sostanziale precarietà segna la nostra vita va accolta e fatta propria.
La pandemia ci ha sbattuto in faccia questa dura realtà. Ci ha messo davanti, in modo brutale, la precarietà sostanziale in cui siamo immersi e il tabù della morte che abbiamo creato nella nostra società.
Come si può verificare, allora, se la morte e il dolore sono integrati nella nostra vita?
Non penso che si possa rispondere facilmente a questa domanda. Ognuno sa, nei vari momenti della sua esistenza, quanto sia difficile dare una risposta univoca e risolutiva a questo quesito.
Tuttavia, la mia personale esperienza – vissuta per anni prima accanto ai malati terminali e poi alle persone che vivono un lutto – mi spinge a sottolineare che la consapevolezza della nostra fine e il coraggio di parlarne sono una strada che, seppur accidentata e non sempre facilmente percorribile, ci fa assaporare con pienezza la vita.
Gustare il presente fino in fondo
Non credo di dire nulla di nuovo e già tanto è stato pronunciato e scritto su questo, fin dall’Antichità. Mi limito a ricordare che avere consapevolezza che dobbiamo morire e che la nostra vita terminerà, è di sprone, perché la viviamo fino in fondo, coscienti che tutto avrà una fine e che la vita, proprio per questo, non va sprecata. Impariamo quindi a stare nella vita presente – crediamo o meno che continui dopo la morte -, a gustarla fino in fondo, senza essere attanagliati dal passato o dal futuro imminente che, a volte, ci fa ancora più paura del passato, spesso ricco di bei ricordi. Consapevoli di essere finiti e limitati, dunque, non cessiamo mai di cercare di vivere intensamente nel presente. Questo significa imparare ad amare e comprendere pure la fatica di vivere che, ogni giorno, le fasi dell’esistenza ci riservano. Vuol dire arrivare anche alla consapevolezza che, per vivere fino in fondo, è necessario far posto anche alla tristezza che, come dice il monaco Enzo Bianchi, “si affaccia nella sua sobrietà come malinconia, turbamento dominato, silenziosa mancanza”. Egli ricorda che gli uomini e le donne dell’antica tradizione cristiana, parlavano di ‘radiosa tristezza’, perché è “come la luce del tramonto che fa palpitare il cuore, fa tacere il cuore umile non altero e ci fa attendere un altro giorno”. Recita un haiku (componimento poetico nato in Giappone composto da soli tre versi), citato sempre da Bianchi:
“Il camino è acceso, il silenzio mi avvolge, gusto la tristezza!”
Maria Augusta De Conti – ADVAR Rimanere Insieme